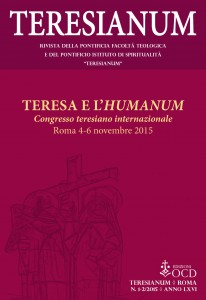Archivi: Downloads
Guida Accademica 2023-2024
C. Betschart, OCD: L’umano, immagine filiale di Dio. Un’antropologia teologica in dialogo con l’esegesi
 Christof BETSCHART, L’umano, immagine filiale di Dio. Un’antropologia teologica in dialogo con l’esegesi, Queriniana, Brescia 2022.
Christof BETSCHART, L’umano, immagine filiale di Dio. Un’antropologia teologica in dialogo con l’esegesi, Queriniana, Brescia 2022.
Secondo la Genesi, l’uomo e la donna sono stati creati “a immagine di Dio”. Questa affermazione, nonostante la sua apparente semplicità, è tra le più discusse e ambigue della tradizione giudaico-cristiana. Cosa può significare per gli esseri ambivalenti che siamo? Rispondendo, l’autore colma una lacuna nella teologia (francofona) basandosi nella sua elaborazione sistematica su uno studio approfondito dei testi biblici. La rilettura cristologica dell’immagine di Dio che identifica in Cristo sia il prototipo che il modello di tutti gli esseri umani viene prolungata con un’interpretazione filiale. La tesi che l’immagine di Dio consista nella filiazione divina viene sviluppata per rendere più concreta l’immagine creata e ricreata, ma anche per rivisitare alcune grandi questioni dell’antropologia teologica recente come il rapporto tra natura e grazia, la mediazione cristologica dell’antropologia e viceversa, il binomio essere e relazione.
Editrice Queriniana
Collana BIC, 213
Brescia 2022
Titolo originale: L’humain, image filiale de Dieu. Une anthropologie théologique en dialogue avec l’exégèse
Traduzione dal francese: Manuiela Romano
Pagine: 395
C. Betschart – M. M. Romano (edd.): Teologia dell’amore. Prospettive teologico-filosofiche in dialogo con il Carmelo
Christof BETSCHART e Maria Manuela ROMANO (edd.), Teologia dell’amore. Prospettive teologico-filosofiche in dialogo con il Carmelo, Città Nuova, Roma 2023.
«Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore» (1Gv 4,7-8).
A partire da questo passo della Prima Lettera di Giovanni, il tema perennemente rilevante dell’amore è stato ripreso e approfondito da un gruppo di ricerca – nato durante la pandemia attraverso alcuni incontri online e successivamente con un seminario di due giorni presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum a Roma – che ha cercato di riflettere insieme sull’amore proprio a partire dall’autorivelazione di Dio come amore e dunque anche come origine dell’amore umano.
Frutto di questi incontri tra giovani ricercatori è il libro pubblicato con il titolo: “Teologia dell’amore. Prospettive teologico-filosofiche in dialogo con il Carmelo” – a cura di Christof Betschart e Maria Manuela Romano – nel mese di marzo 2023 dall’editrice Città Nuova, nella collana “Teologia” diretta da Piero Coda .
Saverio Cannistrà, Valentina Gaudiano, Lukasz Strzyz-Steinert, Luca Bassetti, Adrian Attard, Christof Betschart, Maria Manuela Romano, Iacopo Iadarola, Iain Matthew e Robert Cheaib, nei loro incontri di ricerca e riflessione collettiva, si sono dati l’obiettivo di riflettere non solo sull’amore come tale, ma sull’amore in dialogo con le figure del Carmelo, soprattutto con Teresa d’Avila, Giovanni della Croce e Teresa di Lisieux, ma anche con Edith Stein.
L’intuizione di base di questo volume proviene da un contributo di Saverio Cannistrà sulla scienza dell’amore in Teresa di Lisieux: «una teologia dell’amore, cioè una teologia centrata sull’amore come sul suo principio fondamentale e normante, una teologia, per così dire, agapocentrica, adeguata al nostro tempo, è ancora da sviluppare, nonostante i tanti precorrimenti nella storia della tradizione cristiana».
Certamente, una riflessione sull’amore si può proporre in qualsiasi università o facoltà teologica, ma il Teresianum ha la particolarità di avere due specializzazioni che in un certo senso ci predispongono ad approfondire questa tematica, cioè la specializzazione in teologia spirituale con un forte accento carmelitano e l’antropologia teologica nella quale cerchiamo di introdurre una riflessione sempre più approfondita sull’amore.
Ognuno dei dieci Autori ha contribuito con la propria competenza e con la propria personalità, ognuno ha cercato di rendere conto del fatto che soltanto partendo dall’amore di Dio si può arrivare all’amore riversato nel cuore umano, inteso dagli autori carmelitani come progressiva assimilazione all’amore divino, cioè come unione trasformante di amore. Questa assimilazione viene da loro descritta con le metafore della filiazione, del matrimonio o ancora dell’amicizia. L’amore filiale, sponsale, di amicizia, nella prospettiva cristiana e carmelitana, non può essere inteso altrimenti che come responsivo; dunque è essenzialmente relativo all’amore ricevuto. Nel mondo del Carmelo colpisce, a questo proposito, il testo forse più conosciuto e citato di Teresa di Gesù nel libro della Vita sulla preghiera. Caratterizza la preghiera come un tratar de amistad. Segue però un punto importante, cioè il fatto che è il dialogo amoroso diventa possibile soltanto nella misura in cui si sa di essere amati da Dio. Questa esperienza dell’amore si pone come condizione di possibilità di una risposta d’amore.
Compendio delle norme tipografiche
Compendio delle norme tipografiche
Bibliografia su Santa Teresa di Lisieux
Depliant Generale 2022-2023
Guida Accademica 2022-2023
C. Betschart, OCD: L’humain, image filiale de Dieu. Une anthropologie théologique en dialogue avec l’exégèse
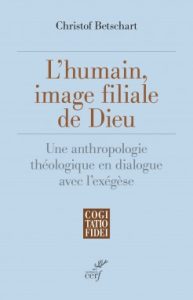 Christof BETSCHART, L’humain, image filiale de Dieu. Une anthropologie théologique en dialogue avec l’exégèse, Éditions du Cerf, Paris 2022.
Christof BETSCHART, L’humain, image filiale de Dieu. Une anthropologie théologique en dialogue avec l’exégèse, Éditions du Cerf, Paris 2022.
Secondo la Genesi, l’uomo e la donna sono stati creati “a immagine di Dio”. Questa affermazione, nonostante la sua apparente semplicità, è tra le più discusse e ambigue della tradizione giudaico-cristiana. Cosa può significare per gli esseri ambivalenti che siamo? Rispondendo, l’autore colma una lacuna nella teologia (francofona) basandosi nella sua elaborazione sistematica su uno studio approfondito dei testi biblici. La rilettura cristologica dell’immagine di Dio che identifica in Cristo sia il prototipo che il modello di tutti gli esseri umani viene prolungata con un’interpretazione filiale. La tesi che l’immagine di Dio consista nella filiazione divina viene sviluppata per rendere più concreta l’immagine creata e ricreata, ma anche per rivisitare alcune grandi questioni dell’antropologia teologica recente come il rapporto tra natura e grazia, la mediazione cristologica dell’antropologia e viceversa, il binomio essere e relazione.
Éditions du Cerf
Collection Cogitatio Fidei, 315
Paris 2022
Pagine: 528
ISBN : 9782204147309